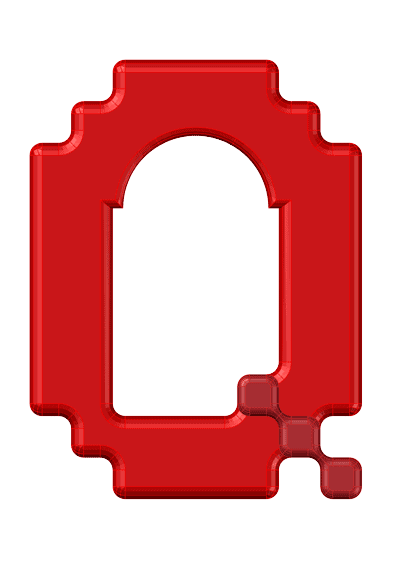Nella nostra famiglia pensiamo che Carlo, mio padre, sia stato un grande narratore e inventore di favole. I suoi racconti, di ambientazione prevalentemente boschiva e montana, prendevano spunto dalla saga di J.R.R. Tolkien, che mio padre epurava dagli elementi più spaventosi, prediligendo episodi della vita quotidiana degli Hobbit nella Contea. C’erano poi storie di orsi parlanti e di gnomi che si costruivano un lettino con mezzo guscio di noce, liberamente tratte dai classici della tradizione favolistica.
Ai miei figli, poi, amava raccontare la favola dell’ Uccel grifone, una parabola sull’amore fraterno, che ho scoperto far parte delle Fiabe italiane raccolte e trascritte da Italo Calvino.
La passione di bambina per quei racconti, e in generale per la letteratura favolistica narrata, è proseguita anche in età adulta, forse per cercare di trattenere nella mia vita quegli spazi di condivisione magica. Mi sono infatti occupata di testi rinascimentali d’occasione, poveri opuscoli, a volte di un solo foglio, che i colporteurs e i cantastorie portavano nelle proprie bisacce, recitavano e vendevano nelle piazze. A volte gli stessi editori di questi pamphlet erano attori, interpretando pubblicamente e in prima persona le opere che stampavano.
Si trattava di ‘favole per adulti’ che potevano essere, ad esempio, drammatizzazioni tratte dall’Orlando Furioso, magari accompagnate da grandi xilografie con brevi testi che raffiguravano i protagonisti della storia come una sorta di protoscenografie, antenate dei cartelloni nell’Opera dei pupi siciliani (fig.1). Ma erano anche narrazioni pubbliche su fatti realmente accaduti, come le più famose battaglie che insanguinarono la Penisola durante le Guerre d’Italia della prima metà del Cinquecento (Urbini 2019).
In alcuni casi artisti che conosciamo per importanti commissioni sul fronte delle cosiddette arti maggiori – pittura e scultura in particolare –, illustravano queste povere carte che contenevano barzellette, frottole, e commedie. Uno dei più prolifici su questo fronte fu l’anticlassico Amico Aspertini che disegnò, ad esempio, la vignetta in apertura della Comedia di più frati da recitare ad ogni convito; li quali per seguire amore lassaro il convento, oppure le visioni e i voli mistici di Colomba da Rieti, un testo che più favoloso di così non si può… (Urbini 1997)
Coltivando le mie predilezioni, ho poi incrociato le traiettorie di Ernst Bloch e Walter Benjamin, che hanno manifestato grande interesse per queste produzioni letterarie.
Il loro sguardo si rivolge in senso lato verso la cultura popolare narrata, di cui la favola, di qualsiasi tradizione ed epoca, è parte essenziale. Ecco che quella stessa letteratura di colportage che si affermò nell’editoria rinascimentale continua a raccogliere, nei secoli, come una sorta di pesca a strascico, leggende, miti, parabole, massime di saggezza per allietare e curare lo spirito e il corpo. Queste forme narrative sono ritenute da Bloch e Benjamin antitetiche al romanzo, per i loro principi compositivi, la materia narrata, il tipo di ricezione.
Il romanzo è un’esperienza solitaria, sia per quanto riguarda la creazione del testo sia per come viene fruito (Boella in Ernst Bloch, Tracce, p. XIV e seguenti). La materia della narrazione favolistica si costruisce nel tempo, per strati sovrapposti e montaggi di cui sono responsabili, come artigiani, tutti coloro che raccontano e ascoltano. È un’esperienza corale, prevede la presenza di un pubblico che è spinto dalla narrazione ad aprirsi verso ciò che è lontano e diverso, al contrario del romanzo, un sentiero che conduce all’interno della propria soggettività e alla ricerca del rispecchiamento.
Benjamin, riferendosi agli ascoltatori di racconti, definisce il loro atteggiamento ‘distratto’: e infatti possiamo immaginare, nel passato, le persone che tessevano e filavano mentre il narratore parlava, e pensiamo anche a noi, oggi, mentre guidiamo o cuciniamo ascoltando un podcast. Allora come ora non si è attenti ai particolari della storia, ma al suo insieme, che a nostra volta faremo rinascere, narrandolo, arricchito dalla nostra interpretazione.
Queste combinazioni, secondo Bloch e Benjamin, erano potenti e vitali antidoti all’omologazione borghese e all’appiattimento classicista dell’arte. L’omaggio di Bloch nei confronti di questi temi si materializza nella raccolta di racconti filosofici – più o meno legati al mondo reale – intitolata Spuren, tracce, pubblicata nel 1930. Il legame di Benjamin con il mondo non ancora deformato dell’infanzia, anche se non è stato sistematico, ha un portato estremamente significativo. Collezionista in prima persona dei ‘relitti di un mondo di sogno’, dedicò ai racconti per ragazzi una serie di ‘narrazioni radiofoniche’ trasmesse da due emittenti tedesche, di Berlino e Francoforte, fra il 1929 e il 1932.
Salvando e divulgando sovversivamente storie in procinto di scomparire, Benjamin incoraggia la sete di sapere e lo spirito critico dei ragazzi, evitando affermazioni e disseminando piuttosto indizi e dubbi intorno ai quali costruire la propria strada nel mondo (Schiavoni in Walter Benjamin. Burattini, streghe e briganti, pp.15-17).