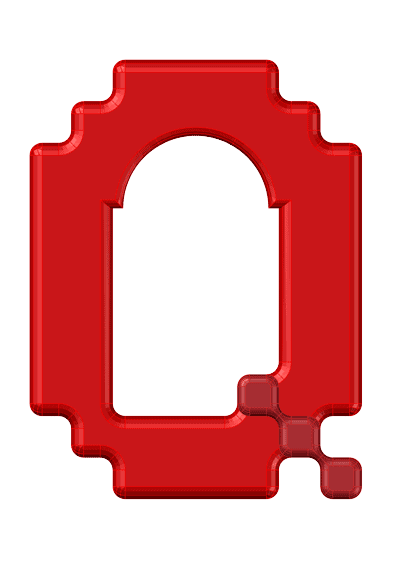“Chiedo scusa alla favola antica,
se non mi piace l’avara formica.
Io sto dalla parte della cicala
che il più bel canto non vende, regala.”
Con questa meravigliosa quartina, che ribalta la morale della celebre favola di Esopo, si concludono le Filastrocche in cielo e in terra di Gianni Rodari. Alla formica, più in dettaglio, chiude l’ultimo dei sette capitoli che compongono la raccolta, intitolato Le favole a rovescio[1]. E così, tirato amabilmente per il bavero da un amico fraterno[2], provo ad aggiungere al Suo il mio ricordo di scolaro di mezzo secolo fa. Per l’occasione, mi sono avvalso di una consulenza intra-familiare: quella di mia madre Antonietta che, nella scuola elementare del quartiere “Serra Venerdì” di Matera, ha insegnato per oltre trent’anni, dal 1962 fino al pensionamento. Un arco di tempo che le ha consentito di essere stata la maestra dei figli di molti dei suoi alunni.
Nicola, come di consueto, ha ragione. La nostra fu una «scuola favolosa». Una favola, sì, ma “rodarianamente” a rovescio. Ed è agevole intendere il perché.
Il rione di Serra Venerdì fu costruito a metà degli anni Cinquanta per accogliere la prima ondata di persone (più o meno forzatamente) sfollate dai Sassi. Nel volgere di poco, braccianti, operai, piccoli contadini e artigiani – mediamente con un bassissimo livello d’istruzione – furono catapultati nelle nuove case popolari. Tant’è, come registra la penna affilata e antiretorica di Mariolina Venezia, il quartiere si meritò presto «l’appellativo di rione Apache, perché dentro ci erano finiti gli ultimi degli ultimi, quelli che abitavano nelle grotte e non avevano mai visto un bagno né conoscevano l’acqua corrente. Nacque lì la leggenda delle famiglie che coltivavano il prezzemolo nella vasca»[3]. Parentesi: io sapevo nel bidè.
Come si vede, c’erano tutti gli ingredienti di contesto per la creazione di una tipica scuola-ghetto, tutt’altro che favolosa. Di quelle a elevata concentrazione di alunni provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati e alle quali – chi può – tende premurosamente a non iscrivere i propri pargoli[4]. E, invece, no! Alla maniera di una favola a rovescio, quella scuola di periferia ha sovvertito lo scontato finale: anziché abbandonarsi a un destino di segregazione, si è presto accreditata come una delle migliori della città. Una scuola ambita, tanto da attirare molti bambini dai quartieri “borghesi”, dove si ergono bei condomini a tre piani, circondati da cortili verdeggianti e (almeno allora) ben curati. Arrivarono, mi ha detto mia madre ieri al telefono, «i figli dei diplomati e, persino, dei laureati». A Matera, all’epoca, nota da par suo l’amica Mariolina, bastava avere il padre geometra per ritenersi «di appartenere all’alta società»[5]. Comunque sia, quanto ci fece bene quell’entropia.
A chi si deve questo miracolo?
Nicola attribuisce molti meriti all’architettura. Anch’io, per quel che vale, la penso così. Aggiungo, però, che la delicata bellezza di quel rione è più visibile agli occhi dei contemporanei di quanto non fosse stata a quelli dei suoi primi abitanti.
Negli anni Sessanta (la fonte è sempre mia madre), i piccoli alunni erano soliti dire: «ieri sono stato/stata a Matera». I loro genitori, in un crescendo d’amarezza, raccontavano alla giovane maestra che a Serra Venerdì avrebbe dovuto sorgere un cimitero, ma che l’amministrazione comunale, avendo trovato quel terreno inadatto per i morti, aveva ben pensato di utilizzarlo per seppellirci i vivi. Eppure, parola di Google Maps, meno di un chilometro e mezzo separa il centro del quartiere da piazza Vittorio Veneto, il cuore della città. All’evidenza, la distanza percepita non era fisica.
Diversamente dalla bellezza del rione, quella delle due scuole “gioiello” – la materna e l’elementare – fu da subito a tutti manifesta. Ampie aule finestrate, giardino e palestra. Credo sia stato questo il principale contributo di Luigi Piccinato alla nostra causa, il tris d’assi calato sul tavolo dalla buona architettura. Ma, fatto il contenitore, bisognava fare i contenuti.
È ovvio, del tutto ovvio, che quelle mura sarebbero state soltanto delle belle mura se al loro interno non fosse entrata la luce portata da una comunità composta da direttori didattici capaci, bidelli affettuosi, insegnanti competenti e appassionati.
Anche i genitori fecero la loro parte, tutti, direi. Quelli più “semplici” gratificando i maestri con profondo rispetto; gli altri, i “diplomati e i laureati”, mettendo a servizio di tutta la scuola (non solo, come usa, a vantaggio dei propri figli) se stessi e la loro rete di conoscenze.
Tra questi ultimi, mi piace ricordarlo, spiccò per generosità il dott. Mario Salerno, il padre di Nicola. Grazie a Lui, per esempio, oggi posso raccontare tronfio – per la serie ogni occasione è buona per vantarsi di qualcosa – di aver scattato la mia prima fotografia sotto la guida prestigiosissima di un altro Mario: Mario Cresci. Inoltre, io lo so, ma non ho le prove, che ci fu (anche) Lui dietro l’organizzazione di una memorabile visita di Rodari nella palestra della nostra scuola.
A tacer d’altro, il 1978 è – per chi si occupa di diritto – l’anno della legge Basaglia, della legge sull’interruzione volontaria della gravidanza e di quella istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. Nei miei ricordi di bambino, però, è soprattutto l’anno dell’incontro con Gianni il Favoloso. Di quel giorno rammento l’emozione, l’entusiasmo, l’allegria. Lo scrittore di Omegna[6] seguì un copione ben rodato[7], lesse un racconto e rispose alle domande dei bambini. Anche a quella più scontata, che arrivò puntuale come un treno giapponese: «come fai a inventare le filastrocche?»[8]. E lui, va detto, non parve del tutto impreparato. All’impronta, si fece suggerire due parole a casaccio e le intrecciò con il filo della fantasia[9].
Dopo qualche ora, Rodari se ne andò, la palestra si svuotò e vi rimasero solo nuvole di polvere e noi della classe. Il maestro Moliterni, come sempre elegantissimo nel suo abito gessato e cravatta, prese il pallone e – da una distanza che a me parve siderale – fece canestro. Scoppiò l’applauso!
Gianni Rodari morì a Roma il 14 aprile 1980, aveva 59 anni.
A questo proposito, mia madre ha un piccolo cruccio. All’epoca, la scuola elementare di Serra Venerdì non aveva ancora un’intitolazione, e lei propose di dedicarla alla memoria di Rodari. L’idea, però, non fu accolta. Peccato: chi meglio di lui per una scuola favolosa?
Avanzo un piano B: perché non intitolargli la palestra? Non è mai troppo tardi…