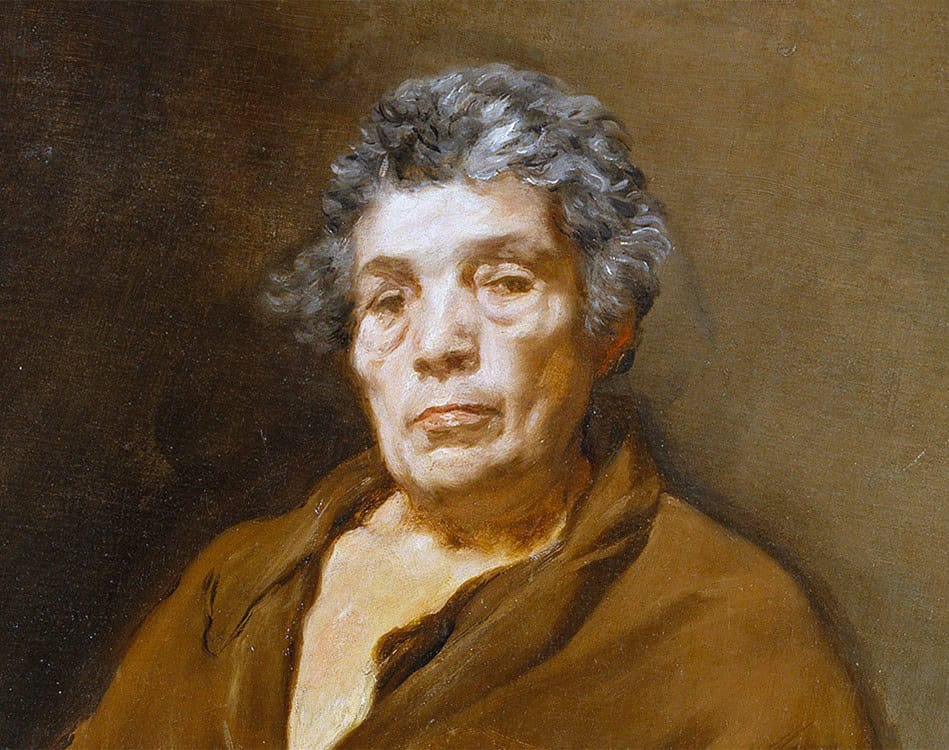Le favole hanno sempre avuto un ruolo cruciale nella formazione del pensiero umano, trasmettendo insegnamenti e prescrizioni morali attraverso storie semplici, vere e proprie metafore della vita, sempre all’insegna di un concreto riferimento all’esperienza umana. Tra le più celebri, la favola de “La volpe e l’uva” di Esopo si distingue per la sua capacità di rappresentare un efficace espediente narrativo circa la natura del desiderio e dell’autoinganno. Narra infatti di una volpe affamata che, camminando nel bosco, vede un succulento grappolo d’uva pendere da una vite. Saltando ripetutamente, cerca di afferrarlo, ma senza successo: il grappolo è situato troppo in alto. Dopo numerosi tentativi falliti, la volpe, frustrata, se ne va borbottando: “Tanto quell’uva è acerba”.
Questo antico racconto è un esempio perfetto di un fenomeno psicologico accuratamente studiato dallo scienziato sociale di origine norvegese Jon Elster: il cosiddetto “wishful thinking”, ovvero la propensione, tipica della natura umana, a sviluppare un pensiero illusorio rispetto alle proprie capacità, che può indurre le persone a modellare le proprie credenze sulla base di ciò che desiderano sia vero.
In questo modo, modificando le proprie credenze, si può incidere in maniera determinante sulle proprie preferenze, escludendone alcune il cui perseguimento ci risulterebbe particolarmente difficile o ostacolato da molteplici avversità. Per dirla altrimenti: quando non possiamo ottenere qualcosa, tendiamo a sminuirne il valore al fine di ridurre, quando non addirittura annullare, la frustrazione che possiamo derivare dall’impossibilità di soddisfare un nostro desiderio. Tale fenomeno è alla base di molte delle nostre azioni quotidiane e, secondo Jon Elster, rappresenta un classico esempio di come siamo in grado di adattare le nostre preferenze a seconda delle circostanze in cui ci troviamo.
In tal senso, quando un obiettivo diventa irraggiungibile, tendiamo ad adattare le nostre preferenze in modo da escluderne o limitarne la desiderabilità, al fine di evitare quella spiacevole sensazione che siamo soliti provare di fronte a un fallimento.
L’adattamento delle preferenze è perciò un meccanismo inconscio che ci permette di affrontare le sconfitte senza subire un impatto emotivo oltremodo eccessivo. La volpe, non potendo raggiungere l’uva, cambia la sua valutazione: invece di ammettere che non riesce a prenderla, si convince che non valesse la pena di essere desiderata.
Esempi di “wishful thinking” nella nostra esperienza quotidiana ce ne sono molteplici. Nel lavoro, per esempio, se non riusciamo a ottenere una promozione, cerchiamo di convincerci che il nuovo ruolo che saremmo andati a ricoprire sarebbe stato troppo stressante e che, in fin dei conti, non valeva la pena ottenerlo. Nelle scelte di consumo, ancora, se non riusciamo ad acquistare un certo bene, cerchiamo di convincerci che non fosse così bello o utile. Il “wishful thinking” si manifesta anche nelle relazioni sentimentali quando, dopo un rifiuto amoroso, ci sforziamo di dire che la persona di cui ci eravamo innamorati non fosse così interessante e affascinante come ci eravamo abituati a pensare.
Il “wishful thinking”, per come lo abbiamo descritto seguendo le riflessioni teoriche di Jon Elster, non riguarda solo la psicologia degli individui, ma influenzare anche le decisioni di attori politici e istituzionali.
Anzi, su questo terreno, quando viene alimentato anche da una comunicazione che prende a diffondersi nell’opinione pubblica, può risultare pure più efficace che sul piano individuale. Stando all’attualità, un esempio molto significativo di “wishful thinking” è quello in cui l’Unione Europea ha negli ultimi anni discusso e affrontato questioni molto controverse, come la gestione delle crisi economiche o le relazioni con le potenze mondiali nel contesto internazionale.
È infatti innegabile che spesso l’Unione Europea adotta strategie basate su una visione eccessivamente normativa e oltremodo ottimistica della realtà, evitando in questo modo di riconoscere l’esistenza di propri limiti o vincoli difficilmente superabili per affrontare con la necessaria efficacia priorità e urgenze che si impongono nella sua complessa agenda politica.
Nella gestione delle crisi finanziarie, l’Unione ha più volte espresso fiducia nella capacità dei meccanismi di mercato di autoregolarsi, senza però considerare adeguatamente le implicazioni sociali delle politiche di austerità. Campione di questo atteggiamento, in anni recenti, è stata soprattutto la Germania, che insieme ai cosiddetti paesi frugali (Danimarca, Paesi Bassi, Svezia e Austria), almeno fino alla nuova stagione di politica economica inaugurata con Next Generation EU e quindi con i Recovery Plan, ha teso a sottovalutare la necessità di interventi di sostegno agli Stati membri, in nome di una priorità di principio assegnata alle politiche di rigore rispetto a quelle per la crescita e lo sviluppo.
Nell’illusione che fosse sufficiente gestire al meglio i conti pubblici per assicurare prosperità e tenere lontano le crisi economiche dal Vecchio continente. Un primo importante passo per infrangere questa illusione fu il famoso discorso pronunciato da Mario Draghi, allora Governatore della Banca Centrale Europea, quando a seguito della crisi finanziaria dei subprime che colpì anzitutto il debito sovrano di alcuni stati membri, cioè Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda e Grecia, sostenne che avrebbe fatto tutto ciò che era necessario (“Whatever it takes”) per salvare l’euro dall’ondata speculativa che lo stava colpendo sui mercati delle valute. Con quel discorso prese forma la strategia del “quantitative easing”, che permise alla BCE di salvare la moneta comune. E possiamo a ragione sostenere che, otto anni dopo, in piena pandemia, quell’intervento fece da paradigmatico precedente per la costruzione di Next Generation UE, il piano da 1.824,3 miliardi di euro che diede forma al Fondo europeo per la ripresa deliberato dall’Unione Europea a sostegno degli Stati membri per rilanciare la crescita all’indomani del Covid-19.
Un primo importantissimo e fino ad allora inedito esempio di politica fiscale comune, che tutti auspichiamo abbia aperto la porta a nuovi interventi dello stesso tipo, i soli – insieme alla costruzione di una difesa militare comune (di questo parleremo a breve) – in grado di proiettarci verso un’Europa davvero unita, dal punto di vista politico prima ancora che soltanto sul piano monetario. A questo punto, si tratta soltanto di fare tesoro di queste fondamentali lezioni del recente passato.
Ma anche nell’ambito della politica estera e di sicurezza, l’Unione Europea è vittima di “wishful thinking”, illudendosi che possa continuare a far gravare il proprio sistema di difesa sulla finora decisiva presenza della NATO, senza provvedere direttamente, attraverso la spesa militare dei suoi Stati membri, alla salvaguardia della propria integrità e incolumità. Nel corso degli ultimi tre anni, a causa dell’aggressione perpetrata dalla Russia di Putin nei confronti dell’Ucraina, questo tema è stato al centro dell’agenda politica in maniera ricorrente.
Anche se, fino all’insediamento alla Casa Bianca del nuovo Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ci si era – per l’appunto – illusi di poter procrastinare la soluzione di questo problema in maniera indefinita, rinviandolo a un futuro lontano.
Oggi Trump, con le sue scelte radicali di politica internazionale, in aperta contraddizione con i pilastri su cui si è retta l’alleanza atlantica dal secondo dopoguerra, ci costringe a interrogarci rapidamente e in maniera definitiva su come continuare a contrastare l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e su come creare le condizioni per un’autonoma difesa del Vecchio continente. Però sarebbe bene ricordare come già nel 2015 l’amministrazione americana del primo mandato presidenziale di Trump aveva manifestato l’intenzione di ridimensionare il sistema di sicurezza e difesa assicurato ai paesi europei sotto l’ombrello della NATO, e come già allora la Cancelliera tedesca Angela Merkel avesse sostenuto che era ormai suonata per l’Europa l’ora di diventare adulti (e quindi, militarmente autonomi).
Da quel lontano 2015 sono ormai trascorsi quasi dieci anni, ma l’Unione Europea in tutto questo tempo ha continuato a illudersi che la propria difesa militare non fosse una priorità. La stessa Angela Merkel, dopo quel pronunciamento, non sollecitò nessuna azione comune conseguente.
E così ancora lo scorso anno, nel 2024, i 27 Stati membri dell’Unione Europea si ritrovavano nella situazione paradossale di spendere complessivamente circa 326 miliardi di euro per i rispettivi sistemi di difesa nazionale, poco meno del 2% del PIL dell’intera Unione, senza avere un benché minimo embrione di difesa integrata comune.
È vero che dal 2021 questa spesa è crescita di oltre il 30%, ma è altrettanto vero che per com’è al momento distribuita, oltre che dal 2022 destinata in parte consistente a sostenere l’impegno militare dell’Ucraina contro la Russia, non è ancora in grado di rappresentare un sufficiente sforzo in direzione di un esercito comune. Solo un anno fa, infatti, si stava discutendo della possibilità di costituire una forza di intervento rapido costituita da un contingente multinazionale europeo di circa 5.000 unità. Una dimensione sostanzialmente insignificante rispetto a qualsiasi pur minimo obiettivo di difesa comune.
La storia ci insegna che due elementi costituitivi di ogni stato moderno sono sempre stati il “batter moneta”, intendendo con questa espressione – in chiave aggiornata – l’esistenza di una politica non solo monetaria ma anche fiscale, e il disporre di un esercito. L’Unione Europea, per come la conosciamo oggi, è stata una straordinaria e originale impresa di costruzione istituzionale di un’entità sovranazionale che non ha precedenti nella storia dell’umanità. La costruzione di uno fra i più grandi mercati dell’economia globale, sostenuto da 447 milioni di cittadini, tanti da farne potenzialmente uno degli attori più importanti dello scenario globale, considerato che per esempio gli Stati contano 347 milioni di abitanti. Abbiamo imparato a “batter moneta”, e stiamo iniziando a utilizzarla bene insieme sul piano della politica fiscale (Next Generation UE, docet!) …
Ci manca però ancora un passo: costruire un sistema integrato di difesa comune. Sappiamo che non è cosa facile, anche se per uscire dal paradosso per cui complessivamente spendiamo in difesa 326 miliardi ma non siamo finora stati capaci di trasferire queste risorse (e magari un po’ di più) a livello comunitario occorre anzitutto superare il “wishful thinking” per cui alla nostra difesa ci pensa la NATO e indirettamente gli Stati Uniti. Più che un problema economico è certo si tratti di un problema politico, ma ancor di più sarebbe importante superare l’illusione che ci porta a credere che la difesa comune non sia un nostro desiderio.
Le favole, come quella su “La volpe e l’uva”, rinviano sempre a una “morale”: nel caso del racconto di Esopo si tratta di disvelare la tendenza tipicamente umana a modificare le nostre preferenze per aggirare, non per superare, gli ostacoli. Comprendere questo meccanismo può aiutarci, come individui e come istituzioni, a prendere decisioni più consapevoli, riconoscendo francamente quanto il nostro giudizio possa essere influenzato dall’autoinganno.
Dopotutto, non sempre l’uva è acerba: a volte, si tratta semplicemente di sforzarci per averla alla nostra portata. È questa una “morale” che vale anche per l’Unione Europea, soprattutto oggi, rispetto alle urgenze che ci troviamo a dover fronteggiare, alle quali questa volta non sarà facile e privo di costi sottrarci.