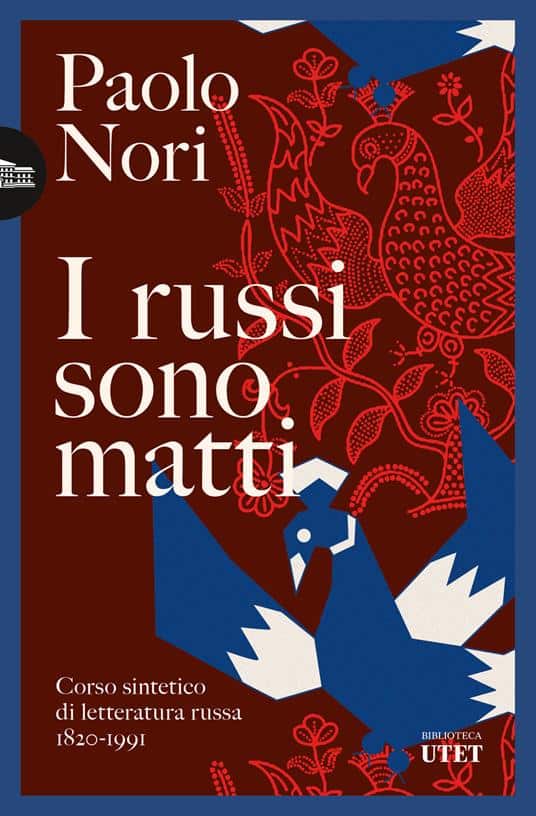Dalla letteratura la Russia che è in noi
“I Russi sono matti” di Poalo Nori è comparso nella linea saggistica della Biblioteca UTET a ottobre 2023. È un compendio di letteratura russa a favore dei non esperti, leggero, ironico e divertente, ma completo e ricco di spunti di riflessione su autori e correnti. Il libro è arrivato al pubblico proprio quando, in Europa e ahimè anche in Italia, hanno cominciato a registrarsi reazioni sbagliate dell’Accademia rispetto alla guerra in Ucraina, con boicottaggi di corsi e seminari di letteratura russa, e addirittura la riemersione di antiche tesi sulla incompatibilità della Russia con l’Europa.
Nell’immediato, il mio interesse per il libro è nato proprio di lì, da quel dibattito che si stava diffondendo proprio nei luoghi – le Università – dove invece dovrebbe rimanere sempre accesa la fiammella della ragione e della speranza. Tra le lezioni sospese c’è stata anche quella tenuta alla Bicocca di Milano proprio dal Nori che intervistato commentò: “È un pessimo segnale che un’università proibisca un corso su Dostoevskij. Proprio in questi giorni in cui crescono le diffidenze e i timori sulla Russia bisognerebbe, invece, parlare molto di più di Dostoevskij, per far capire quanto vicini siamo e quanto ci può fare capire anche di noi!”.
Invito tutti a leggere “I Russi sono matti” senza timore della lunghezza; la prosa è semplice e con esperienza il Nori fa compiere un bel viaggio nella letteratura russa, pieno di spunti, collegamenti al contesto, aneddoti, chiavi di lettura. La letteratura russa ha diverse singolarità rispetto alle altre europee. Quella più macroscopica è che essa è circoscritta nel tempo a poco più di un secolo e mezzo. Inizia negli anni Venti dell’Ottocento con la fine dell’epopea napoleonica e si chiude nei primi anni Novanta del Novecento con il crollo dell’Unione Sovietica.
La letteratura russa era rimasta indietro, restia a cambiamenti e innovazioni, come tutta la Russia estranea alle rivoluzioni liberali del Seicento, alla riforma protestante, ai fermenti illuministici che prepararono il terreno alla Rivoluzione francese. Sino ai primi anni dell’Ottocento essa consisteva o in romanzi stereotipati di imitazione francese, oppure in prose e versi che meccanicamente continuavano la antichissima tradizione bizantina, incentrata su temi religiosi e sul racconto di fatti storici riguardanti la frontiera tra Occidente e Impero ottomano (diffusissime le descrizioni della presa di Costantinopoli nel 1453 e della resistenza dei villaggi sul Mar Nero). Rispetto al resto di Europa, i percorsi si erano divisi quando il decaduto lato latino dell’Impero aveva consegnato l’Ovest alle nascenti comunità nazionali (Francia e Germania sopra tutte), mentre l’Est, ancorato al lato greco dell’Impero, si era trovato depositario della sua continuità secolare, nel tempo lentamente trasmessa alla Turchia e alla Russia. Così Mosca ricevette il testimone di Terza Roma. Tutto cambiò improvvisamente con le guerre napoleoniche, a loro modo un ciclopico disegno di sconfinamento tra affini europei. Il precedente era stato ideato da Carlo Magno mille anni prima. Al seguito dei soldati francesi arrivarono in Russia scampoli di quotidiana modernità; ma a scoprire il mondo nuovo furono soprattutto le truppe dello Zar che, aiutate da Generale Inverno, respinsero e inseguirono la Grande Armée sino a Parigi, attraversando la Germania con tappe a Francoforte, Bamberg e Heidelberg, illustri sedi universitarie. Fu, in solo colpo, un bagno di Illuminismo, Giusnaturalismo, Individualismo, Liberalismo e Libertarismo sul fronte francese e, sul fronte tedesco, di Idealismo e di primo Romanticismo.
Un pot-pourri difficile da digerire dopo secoli di digiuno: in un solo colpo, arrivarono le virtù e i poteri della ragione e anche i limiti della stessa da colmare con volontà, intuito mistico, fede. Che le elaborazioni filosofiche maturate dai due ceppi gallici non fossero poi così antitetiche lo si capì quasi subito, quando Hegel, osservando il fiero ingresso di Napoleone a Jena dopo la vittoria sui Prussiani, lo salutò come espressione massima dello spirito aleggiante sui tempi, strumento di qualcosa di più grande che si era ormai messo in moto senza distinzione tra popoli e senza limitazioni di confini.
Partì allora l’avventura della letteratura russa che di colpo si scosse dal suo stato vegetativo e cominciò a esprimersi in maniera autonoma e genuina. Leggendo il Nori, colpiscono in particolare due aspetti della nuova esperienza letteraria. Il primo è la lingua: sino ad allora si era fatto ricorso al Francese di maniera, perché era la lingua “alta” della diplomazia di corte; dopo lo sconvolgimento napoleonico la Russia scoprì invece di avere un patrimonio linguistico palpitante, sanguigno e dai poteri descrittivi potenzialmente illimitati. Era la lingua del quotidiano delle persone umili, quella delle anime di Gogol’. Il Russo parlato cominciò a diventare inchiostro indelebile sulla carta e lo fece con una velocità e una naturalezza da sembrare non aspettasse altro che venire fuori dal sottosuolo, per parafrasare Dostoevskij.
L’altro aspetto – quello più sorprendente – riguarda i temi e i registri. Partita molto in ritardo, la letteratura russa non si limitò a procedere da quel momento in avanti facendone un anno zero senza memoria, ma rimise in scena, in tempi ristretti e con varianti proprie, esperienze evolutive paragonabili a quelle per le quali erano già passate le letterature dell’Europa dell’Ovest. Non c’era possibilità di dedicare un secolo alla riscoperta dei Classici, uno al Barocco, uno ai Lumi, un altro al Romanticismo, un altro ancora al Realismo e al Verismo, prima di approdare alle turbolenze e alle inquietudini del Novecento; tutto avvenne più velocemente che all’Ovest e quindi con più possibilità di miscuglio. A rileggere la sequenza a distanza di tempo, sembra si fosse accumulato un portato di pensiero ed espressione letteraria che doveva trovare sfogo anche lì, e che riuscì a ritagliarsi il suo spazio e a scegliere le sue menti e le sue mani da scrittore con cui recuperare le stagioni perse.
Lo “stappo” era avvenuto grazie ai napoleonici, ma la reazione dell’Est sembrò piuttosto seguire “affinità elettive” poco razionali e molto più ascrivibili a tensioni fisiologiche esistenziali e romantiche, ora parafrasando Goethe. L’affinità tra Ovest ed Est trova una prova tangibile nella biografia di Dostoevskij che, nato nel 1821 qualche mese dopo la fine di Napoleone a Sant’Elena, trascorse lunghi periodi in Francia, Germania e Svizzera, e che amava follemente e contemporaneamente detestava senza limiti l’Europa dell’Ovest, lui vera e propria incarnazione della Russia schizofrenica che aveva bisogno di accelerare i tempi per ricomporre il suo Io.
L’amore gli veniva dall’affinità provata verso la materia di cui vedeva fatto l’Ovest, l’odio dal sapere l’Est non libero di seguirne le stesse strade senza doversi staccare almeno un po’ dalle sue profondità ataviche, dannose ma fascinose come tutte le profondità.
Per fare solo alcuni esempi e sempre seguendo il Nori, in poco più di un secolo e mezzo la neonata letteratura russa fu capace di occuparsi di denuncia sociale, come in “Anime morte” di Gogol’ e “Povera gente” di Dostoevskij, di riflessioni sugli stravolgimenti della Storia e il passare delle epoche, come in “Guerra e Pace” di Tolstoj, di ipocrisie borghesi e liberazioni individuali, come in “Anna Karenina”, di indagini psicologiche e crisi identitarie, come nelle “Memorie del sottosuolo”, di storie surreali di nasi che camminano e pance di coccodrillo che danno asilo agli sfigati, di crisi mistiche e insuperabili sensi del quotidiano peccato dell’esistenza, di tematiche nichiliste e decadentistiche, come in “Oblomov” e ne “Il burrone” di Gončarov, due opere che, nel parallelismo con l’Ovest, potrebbero rientrare in una sorta di filone di Finis Russiae in anticipo di qualche anno rispetto agli autori della Finis Austriae.
E la lista potrebbe continuare a lungo. Tutti questi temi si concentrarono e sovrapposero, in alcuni casi addirittura nella persona di uno stesso autore. I mille volti di Dostoevskij ne sono un esempio lampante, capace di riassumere in sé gli equivalenti in “pasta” russa di Verga, Capuana, Pirandello, Fogazzaro, Manzoni, De Roberto, Svevo, Buzzati e forse persino Ariosto e Calvino. La biografia di Dostoevskij è un romanzo tutto da leggere che potrebbe essere stato scritto da uno dell’Ovest, Hugo; e qui un altro suggerimento di lettura è ancora Nori con il freschissimo di stampa “Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fëdor M. Dostoevskij”.
Non è un errore parlare di Finis Russiae a inizio Novecento perché la conclusione della letteratura russa è in realtà avvenuta in due momenti distinti. Il primo è segnato dalla Rivoluzione di Ottobre. Col 1917 si aprì una lunga stagione di gelo che vide svilupparsi una borsa nera per i libri e gli scrittori, proprio come quella dei beni di sopravvivenza nei periodi di guerra. Prese piede la cosiddetta “doppia circolazione”: da un lato, gli scritti di regime con imprimatur, scontati, sterili, di propaganda, anche se oggi, col senno dell’approfondimento storico, tutt’altro che privi di interesse; dall’altro lato, l’auto-pubblicazione di nascosto e con mezzi di fortuna per la fruizione di cerchie ristrette, oltre alla trascrizione a mano nottetempo di intere opere, anche dei grandi russi dell’Ottocento, messe all’indice dal Cremlino.
Quella “pulizia” letteraria fu una anticipazione di quanto stava per abbattersi di lì a poco anche sull’Ovest, ulteriore testimonianza, questa volta macabra, di affinità evolutive politiche e sociali europee di cui quello che accade alla letteratura è termometro. Troppo piccolo è questo continente perché restino in disparte e non si influenzino le tante varietà che, nel bene e nel male, esso riesce a nutrire; un natura profonda, questa, che dovrebbe rimanere sempre ben presente quando si affronta il futuro.
Si è già detto che la conclusione definitiva della letteratura russa viene fatta coincidere col crollo del Muro e dell’Unione Sovietica nel 1989. Si aprì allora un’altra fase contraddistinta dalle nuove letterature idiomatiche delle ex Repubbliche sovietiche, già ex domini degli Zar, e dalla nuova letteratura russa, di una Russia fortemente ridimensionata sia geograficamente che geopoliticamente e coinvolta in cambiamenti rapidi e vorticosi. Come per tutte le date di fine e inizio, non manca la usuale dose di convenzionalità, che in questo caso deve anche fare i conti con un sostrato culturale e linguistico, accumulato in secoli di condivisione volontaria e forzata, che ovviamente nel 1989 non è scomparso nel nulla e che, amato o odiato, o più spesso amato e odiato allo stesso tempo come la Francia per Dostoevskij, ha seminato affinità oltre i nuovi confini nazionali, destinate a durare e ad alimentare chissà quante altri squarci, quante fantasie delle letterature. La stessa Russia di oggi ama e contemporaneamente odia la Russia del Novecento.
Il ciclo della letteratura russa termina proprio nell’anno del mio arrivo a Milano per gli studi universitari. Il mercatino delle pulci di Senigallia, che tutti i sabato mattina occupava la darsena alla confluenza tra i due Navigli, si riempiva allora, tra la fine del 1989 e i primi mesi del 1991, di tantissimi oggetti provenienti dall’Est oltre cortina: colbacchi, vestiti, cannocchiali, orologi meccanici, bussole, pezzi di divise dell’Armata Rossa, bauli e casse, icone ortodosse, distintivi dalla grafica improbabile, matrioske, mappe e cartine geografiche, strumentazioni ferroviarie, cartelli stradali, cartoline inneggianti al sol dell’avvenire, e libri, tantissimi libri, nuovi e vecchi. Fu la prima volta che mi capitarono tra le mani dei libri in Cirillico e tra questi anche dei Tolstoj e Dostoevskij in edizioni degli anni Trenta e Quaranta, arrivati per chissà quali vie e passati per chissà quante mani. Soprattutto nelle settimane natalizie del 1989, ricordo una diffusa sensazione di allegro e anche un po’ matto – per dirla col Nori – sconfinamento europeo, che amplificava il mio piccolo personale sconfinamento da Sud a Nord della penisola.
Non fui tra i più pronti a cogliere quell’attimo per visitare l’Est, che allora aveva quasi il sapore di una meta esotica tanto quel confine era entrato dentro di noi. In molti, colleghi del primo anno in Bocconi, si fiondarono senza pensarci due volte a Berlino per vedere passare almeno qualche fotogramma di storia, forse con ancora in testa l’immagine liceale di Hegel che cercava almeno di sfuggita di intercettare la sagoma imperiale di Napoleone a cavallo per il corso di Jena; altri fecero dei Paesi dell’Est le mete di molti viaggi successivi, estivi e infrannuali.
Io invece ho impiegato molto molto di più a superare il meridiano di Trieste ma poi, una volta fatto, devo dire c’ho preso parecchio gusto e del wanderlust non mi sono più liberato! Tra le destinazioni più grandi mi mancano ancora Mosca e San Pietroburgo in Russia e Odessa in Ucraina sul Mar Nero, ma è solo questione di pazientare un po’, aspettando tempi migliori per tornare a sconfinare ancora. Alla fine, se l’etimo non mente, sconfinare significa diventare un po’ affine.