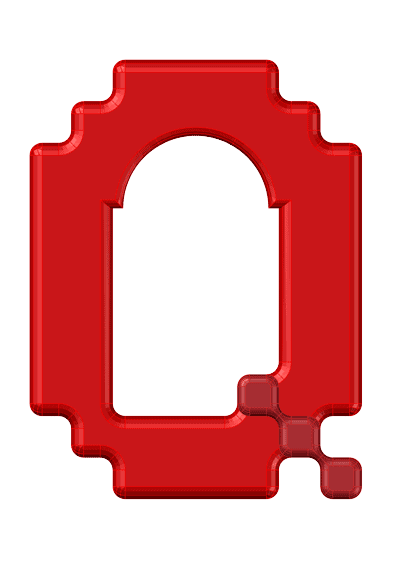Da bambina ero talmente convinta della realtà dei sogni che la volevo trasportare nella vita da sveglia. Prendevo gli oggetti del mondo onirico che mi piacevano per tenerli con me, e la delusione di svegliarmi a mani vuote non mi impediva di continuare a provarci per anni e anni, finché non smisi. I sogni avrebbero guidato comunque la mia vita, anche senza quegli oggetti materiali.
Feci il mio primo reportage dopo pochi anni che lavoravo. Avevo iniziato come fotografa di spettacolo e ritrattista. La fotografia era ed è ancora la realizzazione di un sogno. Il viaggio in Asia pure. Dopo un improvvisato e faticoso trekking su delle colline fatte di giungla arrivammo in un villaggio del popolo Karen a nord di Chiang Mai.
Non era un viaggio turistico organizzato a distanza. La guida, un uomo del posto che accompagnava i viaggiatori stranieri, conosceva una sola parola inglese: yes, e aveva la testa piena delle sue preoccupazioni.
Gli stranieri erano viaggiatori che si spostavano più o meno a lungo, mossi ognuno dalle sue motivazioni. Gli abitanti del villaggio apparivano pacifici e malinconici. Nonostante vivessero in armonia con un paesaggio idilliaco, i loro sguardi erano a volte fissi su qualcosa di invisibile. Per pochi soldi ci ospitarono nelle loro capanne che erano palafitte sotto cui razzolavano maialini scuri che fungevano da operatori ecologici, divorando i pochi rifiuti di una società non consumistica. Ci fecero gentilmente mangiare riso e verdure, dormire nelle loro verande e fumare l’oppio in piccole, lunghe pipe. Il popolo Karen, originario del Tibet e della Mongolia, vive principalmente sul confine tra Myanmar e Thailandia. Vive di agricoltura ed è di religione buddhista e animista in gran maggioranza o cristiana.
Dal 1948, anno della fine del colonialismo inglese, chiede la formazione di uno stato indipendente o almeno autonomo e nel 1949 ha imbracciato le armi contro la Birmania, che l’ha sempre oppresso ferocemente in quanto minoranza. I gentili abitanti del villaggio che ci avevano ospitati erano rifugiati, scappati da un regime brutale, sopravvissuti a chissà quali orrori. Il mio primo reportage venne pubblicato su una rivista ambientalista col titolo “I poveri dell’oppio”. Tornata a casa mi misi al lavoro in camera oscura, in quella sorta di grande utero dove avvengono trasformazioni chimiche e alchemiche, ambiente perfetto per l’elaborazione interiore di un viaggio. Lì capii per la prima volta come le immagini esteriori entrano in relazione più o meno profonda con quelle interiori, e che quello che mi interessava non era l’esotismo ma al contrario una sorprendente, toccante familiarità con l’altro. Era solo l’inizio di una ricerca che ancora continua.
E a un certo punto, vedendo apparire una delle fotografie dei Karen nella bacinella dello sviluppo, mi resi conto che stava avvenendo il trasporto di un oggetto da una dimensione all’altra. La mia missione infantile di dimostrare la realtà del sogno era finalmente compiuta.