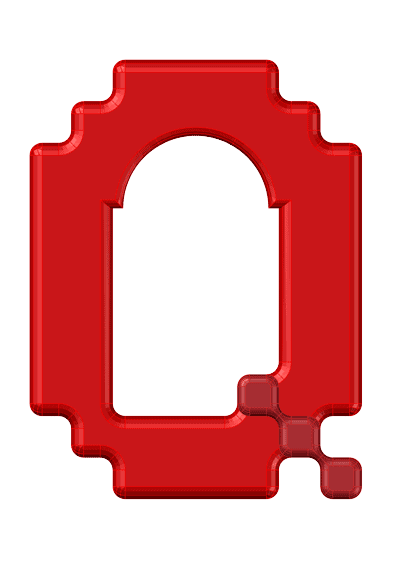Sin da Omero, “poeta sovrano”, la vita degli uomini è stata sovente paragonata alle foglie di un albero: l’immagine è enunciata nell’Iliade durante il dialogo tra Glauco e Diomede (VI, 146-149), e diventa figurazione tradizionale per indicare diversi aspetti della nostra esistenza. In Omero le foglie sono emblema del susseguirsi delle generazioni degli uomini (Leopardi, in un frammento del Canto XLI, scriverà: “disse il veglio di Chio, / conforme ebber natura / le foglie e l’uman seme), in Mimnermo, poeta greco elegiaco, diventano il simbolo della precarietà della nostra misera condizione mortale, come nella celeberrima Soldati di Ungaretti (“Si sta / come d’autunno / sugli alberi le foglie”). Sulla scorta di una similitudine virgiliana (Eneide VI, 305-312), Dante paragona l’accalcarsi delle anime sulla riva dall’Acheronte alle foglie che in autunno velocemente si ammassano sotto gli alberi (Inf. III, 112-116):
come d’autunno si levanle foglie
l’una appresso dell’altra, infin che il ramo
vede alla terra tutte le sue spoglie; 114
similemente il mal seme d’Adamo
gittansi di quel lito ad una ad una
Se l’immagine dell’Eneide si concentra visivamente sull’ingente numero di anime in assembramento in attesa di Caronte, Dante prosegue la metafora vegetale chiamando i peccatori “il mal seme d’Adamo”. In questo caso “seme” significa discendenza dal progenitore della nostra stirpe (“Adamo del quale noi siamo tutti seme”, chioserà Boccaccio), e il “mal seme” identifica coloro che hanno tralignato nel peccato. Ma più spesso seme o radice indicano nella Divina Commedia l’origine di una famiglia o di una dinastia: la coppia di Adamo ed Eva è chiamata “umana radice” (Purg. XXVIII 142); nel canto XX del Purgatorio, Ugo Capeto ammetterà di essere l’origine maligna di una cattiva casata, quella dei Capetingi, con queste parole: “Io fui radice de la mala pianta / che la terra cristiana tutta aduggia” (Purg. XX, 43-44); similmente Carlo II d’Angiò verrà dichiarato meno virtuoso di suo padre Carlo I con l’espressione “tant’è del seme suo minor la pianta” (Purg. VII, 127). E ancora, l’avo di Dante Cacciaguida, usando la voce nello stesso senso ma in accezione positiva, dirà al nipote poeta: “O fronda mia in che io compiacemmi / pur aspettando, io fui la tua radice” (Par. XV, 88- 89). Anche Dio stesso è definito “d’ogne ben frutto e radice” in Purg. XVII, 135.
Al di là delle immagini vegetali che la parola suggerisce, nella Divina Commedia Dante riflette più volte sulla radice della vita dell’uomo, sul senso della sua esistenza e sull’origine dei desideri e delle passioni che animano le nostre vite individuali. Quello che noi siamo, il nostro modo di essere, ha una radice stabilita o siamo invece eterodeterminati da una potenza superiore che traccia anticipatamente il percorso della nostra esistenza terrena? L’aporia del credente di ogni tempo è risolta dall’uomo medievale con la concorrenza di due teorie complementari: le influenze astrali da un lato, ed il libero arbitrio dall’altro, rispettivamente oggetto di estesa discussione nel canto VIII del Paradiso e nel canto XVI del Purgatorio.
Nell’VIII del Paradiso, nel cielo di Venere degli spiriti amanti, Dante dialoga con Carlo Martello d’Angiò, il quale spiega al poeta come mai gli uomini abbiano virtù e talenti differenti:
Dunque esser diverse
convien di vostri effetti le radici: 123
per ch’un nasce Solone e altro Serse,
altro Melchisedèch e altro quello
che, volando per l’aere, il figlio perse. 126
La circular natura, ch’è suggello
a la cera mortal, fa ben sua arte,
ma non distingue l’un da l’altro ostello. 129
Quinci addivien ch’Esaù si diparte
per seme da Iacòb; e vien Quirino
da sì vil padre, che si rende a Marte. 132
Natura generata il suo cammino
simil farebbe sempre a’ generanti,
se non vincesse il proveder divino. 135
Se il mondo è vario, se noi esseri umani sappiamo esercitare le più disparate professioni, se ognuno di noi riesce bene in alcuni mestieri o attività e meno bene in altre, lo si deve unicamente alla Provvidenza divina che ha voluto distribuire tra gli uomini inclinazioni naturali diverse. Queste vengono comunicate alle nostre anime per mezzo dell’influsso degli astri e dei cieli e attraverso la mediazione degli angeli. Ciascuno di noi possiede un talento radicato dentro di sé. Gli uomini hanno predisposizioni e ingegni differenti perché le radici da cui l’anima ha tratto il suo carattere sono diverse e corrispondono ai diversi corpi celesti. Dante stesso nel Convivio spiegava che “quando l’umano seme cade nel suo recettaculo, cioè nella matrice, esso porta seco la vertù dell’anima generativa e la vertù del cielo” (Conv. IV, XXI 4).
Il tema delle influenze astrali si ripete più volte nel poema (cfr. Purg. XVI 73-8 e XXX 109-11). In particolare è significativo Par. II, 115-120, in cui viene detto che i cieli dei sette pianeti ricevono dall’alto la virtù e la diversificano in base alla loro natura (“dispongono a lor fini e lor semenze”) prima di distribuirla agli uomini:
Li altri giron per varie differenze 115
le distinzion che dentro da sé hanno
dispongono a lor fini e lor semenze
Questi organi del mondo così vanno, 118
come tu vedi omai, di grado in grado,
che di sù prendono e di sotto fanno.
Dunque ognuno riceve dagli astri e dai cieli una serie di qualità, doti, attitudini che lo indirizzano ad operare nel mondo. C’è chi è un “politico nato”, come Solone, chi un grande condottiero, come il persiano Serse, chi ancora un sacerdote, e chi, come Dedalo (che perse suo figlio Icaro, secondo il mito, durante la fuga dal labirinto per mezzo di ali di cera) un artista. Dante stesso si dichiara più volte debitore agli astri per il suo ingegno poetico (Inf. XXVI 23-4, Purg. XXX 109-117, Par. XXII 112-4).
Platone aveva insegnato, tramite il mito della biga alata e poi nella Repubblica, che c’era una stretta correlazione tra la composizione della nostra anima e il mestiere o l’occupazione che siamo “psicologicamente” chiamati a fare per avere successo.
La differenza tra un’anima e un’altra è determinata dall’elemento in essa predominante: chi sente dentro di sé una tensione verso il sentimento e lo spirito ha un’anima irascibile (trascinata dal cavallo bianco), ha l’audacia che serve per diventare un buon guerriero; chi invece è attratto dal mondo sensibile e dalle cose materiali (l’anima concupiscibile, retta dal cavallo nero) possiede l’attitudine all’attività manuale o imprenditoriale, e riuscirebbe bene nel fare il contadino, il mercante, l’artigiano; chi invece agisce sotto l’impulso della ragione (simboleggiata dall’auriga del mito platonico), riesce a dominare per mezzo della saggezza tutti gli impulsi, ed è pertanto votato a essere un filosofo ovvero un governante. Dante non è però così categorico e non pone limitazioni ai destini degli uomini.
Se Dio è l’Artefice e il Motore del mondo, l’uomo ha con sé il libero arbitrio, la possibilità di scegliere se dare davvero compimento al suggello che il Creatore, tramite le stelle, gli ha impresso. La teoria è stavolta esposta nei canti centrali del Purgatorio, in particolare nel XVI quando Dante dialoga con Marco Lombardo, ma è ribadita pregnantemente in Par. I, 130-132:
così da questo corso si diparte
talor la creatura, c’ha podere
di piegar, così pinta, in altra parte.
Pertanto, gli astri ci forniscono un indirizzo, ma non predeterminano la nostra esistenza. Come il buon seme ha bisogno di trovare il terreno fertile per germogliare rigoglioso, così per il successo si devono creare le condizioni idonee che permettano al talento personale di potersi esprimere nel miglior modo possibile, assecondando le intenzioni divine che i cieli ci hanno donato. Continua Carlo Martello (Par. VIII, 139-141):
Sempre natura, se fortuna trova
discorde a sé, com’ogne altra semente
fuor di sua region, fa mala prova.
Purtroppo spesso sono proprio gli uomini che non sanno ascoltare la loro natura, e diventano essi stessi primi responsabili degli ostacoli che il nostro talento incontra sulla sua strada (Par. VIII, 142-148):
E se ‘l mondo là giù ponesse mente
al fondamento che natura pone,
seguendo lui, avria buona la gente. 144
Ma voi torcete a la religione
tal che fia nato a cignersi la spada,
e fate re di tal ch’è da sermone; 147
onde la traccia vostra è fuor di strada.
Nel mondo è necessario che ognuno eserciti l’ufficio che meglio si confà alla sua predisposizione d’animo. Per realizzare una comunità statale efficiente, come già aveva ricordato Aristotele nella Politica e nell’Etica Nicomachea, gli uomini devono differenziarsi nei mestieri e nelle arti. Il discorso dantesco non è pero una semplice spiegazione della varietas delle attività umane (cfr. Conv. IV, IV 1-2) ma diventa un monito che ci esorta a recuperare una virtù oggi sempre più rara, il coraggio; non è infatti semplice per un padre lasciare ai figli la possibilità di scegliere in tutta libertà come meglio realizzarsi nella vita; occorrerebbe permettere ad essi di inseguire i propri sogni obbedendo solo a ciò che l’anima “ditta dentro”, senza pressioni e condizionamenti esterni, senza paventati rischi o ansie di fallimento. È infatti rara l’eventualità, come precisa Carlo Martello, che una virtù di un padre trovi prosecuzione nel figlio, perché Dio attraverso le stelle distribuisce le “radici” senza tener conto delle casate (Par. III 129: “non distingue l’un da l’altro ostello”). Pertanto, chi è figlio di un grande politico non è detto che perpetui la professione paterna (cfr. Conv. IV, XX 5: “’l divino seme non cade in ischiatta, cioè in istirpe, ma cade nelle singulari persone”).
I padri però spesso pretendono che i figli seguano le loro orme e continuino il loro operato, incuranti delle attitudini che i figli stessi manifestano. Obbligando ad una forzata vita religiosa chi è nato per essere guerriero (“a cignersi la spada”), o viceversa eleggendo re chi invece dovrebbe essere un predicatore (tal ch’è da sermone), i genitori spesso incentivano nei figli una carriera che non si sposa con le loro inclinazioni naturali. Ecco che il libero arbitrio, che garantisce all’uomo quello spazio di manovra per essere artefici del proprio destino, se usato in modo sbagliato, annulla le predisposizioni buone che provengono dagli astri (cfr. Par. I, 129: “perch’ a risponder la materia è sorda”).
Concludendo: noi uomini abbiano ciascuno dentro di sé quell’afflato divino che il Creatore stesso ha deciso di imprimerci tramite le stelle affinché possiamo dare compimento alle nostre inclinazioni attraverso mestieri, azioni e opere. Tuttavia, c’è una caratteristica che accomuna tutti gli uomini di ingegno, qualcosa che distingue massimamente l’uomo nell’intero Creato, lo eleva al di sopra degli altri animali e lo rende unico nell’universo: è il desiderio della conoscenza, ovvero l’amore per la sapienza pura, senza fini pratici. Aristotele considerava la scienza più alta la metafisica, lo studio dell’essere in quanto tale, senza alcuna implicazione contingente o in divenire (oggetto della sua Fisica). “Tutti gli uomini sono per natura desiderosi del sapere” è proprio l’incipit della Metafisica aristotelica. Il personaggio dantesco che incarna questa sete di conoscenza è, come a tutti noto, Ulisse nel canto XXVI dell’Inferno. Sembra quasi ozioso rammentare la terzina forse più famosa dell’intera cantica (Inf. XXVI, 118-120):
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.
Ulisse sta facendo riferimento alla radice stessa della nostra essenza, la “semenza”, intesa non in senso fisiologico ad indicare le generazioni umane, ma in senso morale ed esistenziale, nell’accezione di “cifra distintiva” dell’Uomo. Cicerone lo aveva ricordato nel De Finibus (V, 48, 8): “Tantus est igitur innatus in nobis cognitionis amor et scientiae, ut nemo dubitare possit quin ad eas res hominum natura nullo emolumento invitata rapiatur”. La voglia di indagare, curiosare, sapere, scoprire, è qualcosa di cui non possiamo fare a meno: non lo facciamo non perché la nostra ricerca abbia per forza uno scopo pratico, ma molto più spesso per il puro gusto di conoscere. Se però la conquista è trionfante, spesso non si tratta di un percorso semplice e privo di difficoltà.
Aristotele, ancora con una metafora vegetale, aveva infatti eloquentemente messo in guardia: “le radici della παιδεία [educazione] sono amare, i frutti invece sono dolci” (Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, V, 18). Ulisse fa leva proprio sulla semenza dei suoi compagni per convincerli ad andare avanti, oltre l’ignoto, oltre le colonne d’Ercole, per dove nessuno prima di allora si era spinto: la dolcezza della scoperta ripaga dell’amarezza e dei rischi connessi al “folle volo”.
Non solo la conoscenza ci dà la soddisfazione di poter manifestare il lato più nobile dell’essere uomini, ma il solo ricordarci della nostra grandezza per mezzo del sapere ci vivifica e ci tiene in vita. Fu così per Primo Levi, quando quella mattina camminò per ore nel Lager di Auschwitz-Monowitz per andare a recuperare il rancio a tutti i detenuti, e raccontò in un misto di francese, tedesco e italiano, il canto di Ulisse ad un suo compagno di sventura: per rimanere attaccato alla vita nella brutalità e bestialità disumanizzante del Lager, come registrò nel suo “Se questo è un uomo”, amava riandare con la memoria alla Divina Commedia, ai versi che aveva imparato a scuola e che spesso recitava tra sé. E quando quel giorno raccontò di Ulisse, giunto alla celebre terzina della “virtute e canoscenza”, Levi stesso sentì un sussulto dentro di sé: “come se anch’io lo sentissi per la prima volta: come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”.
Perché allora, potremmo chiederci, se Levi è stato tenuto in vita dall’Ulisse di Dante e dalla sua semenza di uomo amante del sapere, l’Ulisse dantesco è stato invece condannato alla morte dallo stesso Creatore? La risposta sta nella direzione che deve prendere la nostra conoscenza: essa deve essere lecita e permessa da Dio, poiché ci sono cose che solo Dio sa e che non è dato all’uomo scoprire. Dante lo dice chiaramente nel Purgatorio (III, 37-39): “State contenti, umana gente, al quia; / ché se potuto aveste veder tutto, / mestier non era parturir Maria”. L’esortazione ai compagni espressa nella “picciola orazione” dall’eroe greco, se è nobile negli intenti, è fraudolenta, perché egli era chiaramente consapevole del pericolo cui andavano incontro lui e i suoi compagni, benché, da pagano, non potesse conoscere gli obblighi imposti dal Dio cristiano.
Ad ogni modo, ne ricaviamo un’altra lezione dantesca: se la radice (semenza) dell’uomo risiede nella voglia di conoscere, solo la conoscenza votata al bene è ammessa, solo quella perseguita con umiltà etica e morale. Se infatti la conoscenza e la scienza sono usate in maniera deteriore, presto degenerano in perversione, superbia, peccato. Non a caso il contraltare del canto XXVI dell’Inferno è il canto I del Purgatorio: il mare in burrasca del racconto dell’eroe greco lascia il posto ad una spiaggetta animata da cielo sereno, così come la nave di Ulisse che procede nell’Oceano verso la montagna del Purgatorio è sostituita dalla navicella dell’angelo nocchiero che ugualmente trasporta le anime dalla Terra al secondo regno.
Ma il senso dei due viaggi è opposto e la profonda differenza è nell’atteggiamento: Dante si cinge la testa con un giunco, simbolo di umiltà, simbolicamente ammettendo la nostra finitudine nei confronti di Dio. Non a caso, l’inciso “com’ altrui piacque” è presente in entrambi i passi, quasi a suggellare l’antitesi tra l’alterigia di Ulisse e l’umiltà di Dante (cfr. quanto abbiamo scritto nella rubrica relativa alla memoria).
Questo concetto cristiano della conoscenza e questa stessa concezione del nostro animo come elemento sostanziato e dotato di significato per influsso delle stelle in obbedienza al volere divino è una incredibile novità del Cristianesimo. Lo Stoicismo e il Neoplatonismo avevano certamente assegnato all’anima umana una partecipazione al principio universale del Logos (gli Stoici) o dell’Uno (i Neoplatonici), ma nessuna religione aveva prima immaginato che noi stessi fossimo compartecipi del divino solo grazie all’atto di amore (agape) che Dio stesso ha avuto verso di noi. Come scrisse Benedetto Croce nell’opuscolo Perché non possiamo non dirci cristiani: “il suo [di Dio] affetto fu di amore, amore verso tutti gli uomini, senza distinzione di genti e di classi, di liberi e schiavi, verso tutte le creature, verso il mondo, che è opera di Dio e Dio che è Dio d’amore, e non sta distaccato dall’uomo, e verso l’uomo discende, e nel quale tutti siamo, viviamo e ci moviamo”.
In ognuno di noi agisce quindi un pezzo della Provvidenza divina: quello che siamo, che desideriamo, che facciamo, è impressione vivificatrice del Creatore, non semplice emanazione ipostatica, ma una dichiarazione di amore verso l’uomo. Saper ascoltare il nostro cuore e il nostro animo, avere il coraggio di seguire le proprie passioni senza piegarci alle forzature e ai condizionamenti esterni significa per Dante agire nell’ottica del vero cristiano. E dare dignità alla nostra humanitas significa amare il sapere per fare il bene. Non è un’operazione automatica, come per Socrate, per cui conoscere il Bene significava automaticamente metterlo in pratica. L’uomo di Dante può scegliere, è libero di farlo, ma è però consapevole che le nostre radici vengono dall’amore di Dio per noi e sono scritte nelle stelle. Guardare in alto verso Dio non è altro che sapersi guardare dentro. A ciascuno, la sua scelta.