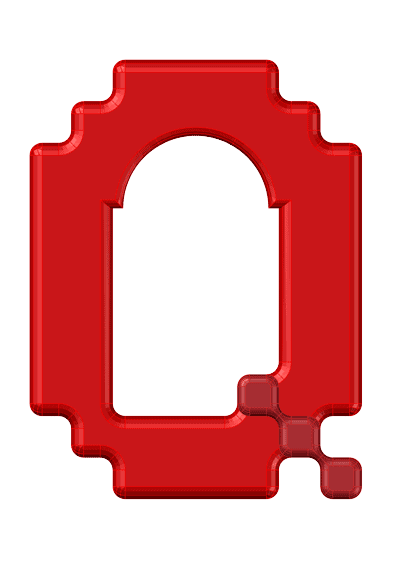Nel 2010 ero stata incaricata di realizzare un libro fotografico sugli ospedali afghani finanziati dall’allora Cooperazione Italiana, ora Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Felice di essere di nuovo in Afghanistan e senza grande preparazione su quanto mi avrebbe aspettato, il primo giorno di lavoro mi ritrovai in una bolgia infernale: il “Centro ustioni” del principale ospedale di Herat, pieno di bambini saltati sulle mine e soprattutto donne autoimmolate.
Per un paio di giorni non fui capace di tirare fuori la macchina fotografica dalla borsa e cercai urgentemente la risposta alla grande domanda del fotogiornalismo su qual è il confine nel mostrare la sofferenza altrui. Fino a quando, una donna che stava per morire, non richiamò la mia attenzione con un gesto facendomi capire che voleva essere ritratta. Realizzai che era una ribelle, e che per rifiutare una vita di schiavitù fino al punto di darsi fuoco, bisogna essere radicalmente ribelli. E su quella comprensione, con profondo rispetto, iniziai a lavorare, mettendomi completamente a servizio, offrendo quel po’ che sapevo fare nella speranza che potesse risultare utile a far sapere cosa stava accadendo e raccogliere anche fondi per l’ospedale. Il ritratto di quella donna è pubblicato nel mio libro “Hospital Life in Afghanistan”; certamente questo non è lo spazio in cui mostrarla. La foto che vedete è di un’altra ribelle che penso si sia salvata.
Non ho ancora una risposta definitiva, che va bene in tutte le situazioni, alla domanda sul limite del mostrare la sofferenza. So che dipende molto dal perché e come si fa, e che è importante che lavori sempre dentro di noi.
Le storie delle autoimmolate, sono tutte variazioni della stessa favola crudele del matrimonio precoce e forzato della povera ragazza o bambina vittima di parenti malvagi (soprattutto suocere e mariti, ma anche cognati, padri, fratelli, o zii ) con un unico finale, il gesto più estremo, carico di disperazione e ribellione, di un numero sempre maggiore di donne afghane: il “khod soozi”, suicidio col fuoco. Quasi tutte le pazienti del Centro ustioni che si erano date fuoco, avevano fra i 13 e i 25 anni, e molte erano belle come la donna ritratta di cui preferisco non dire il nome. Secondo il direttore del Centro, il dottor Mohammed Arif Jalali, le cause che spingono le donne a cospargersi di benzina e darsi fuoco sono da attribuire alla povertà (il 90-95%), all’ignoranza, ai matrimoni forzati, alla poligamia e a tutto quel sistema patriarcale appoggiato dai mullah che fa sì che, nonostante la legge afghana all’epoca vietasse il matrimonio prima dei 16 anni, il 60% delle ragazze venivano ancora di fatto vendute anche all’età di nove-dieci anni.
Con il ritorno al potere dei talebani, le donne afghane si ritrovano in una situazione ancora peggiore. Nonostante le promesse sul rispetto dei diritti umani dell’accordo di Doha (il trattato di pace fra i talebani e gli USA del 2020), gli studenti coranici hanno emesso una serie di editti e decreti che le hanno progressivamente e sistematicamente bandite dalla vita pubblica: dal lavoro (tranne poche eccezioni), dagli spazi pubblici, parchi, palestre e piscine, dai programmi televisivi e soprattutto, le uniche al mondo, dall’istruzione secondaria e superiore, e in alcune province da oltre la terza classe della primaria.
Per di più, nemmeno l’Occidente ha mantenuto le sue promesse sugli aiuti e sull’accoglienza, ritirando i finanziamenti che coprivano il 75% della spesa pubblica e il mantenimento del servizio sanitario, e congelando 10 miliardi di soldi afghani nelle sue banche. In Afghanistan ora il 98% della popolazione vive sotto la soglia della povertà e 28,8 milioni (numero che cresce velocemente) cioè 2/3 del totale sono bisognosi di assistenza umanitaria. E, secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, lo scorso anno su più di 270.000 afghani rifugiati nei Paesi confinanti bisognosi di protezione permanente, l’Unione Europea ne ha accolti 271: lo 0,1%!
Gli afghani sono stati abbandonati nelle mani dei talebani, e le donne sono costrette a un apartheid di genere, unico al mondo. Fino a dove arriverà il limite della loro sopportazione? Qual è il nostro limite nel mostrare la loro sofferenza?